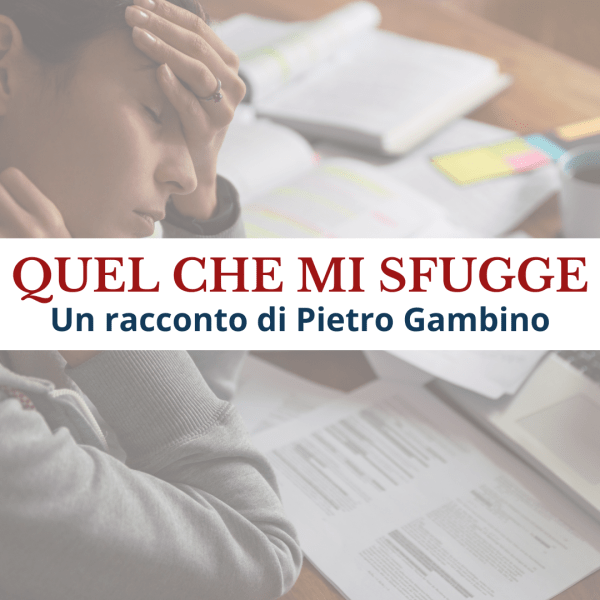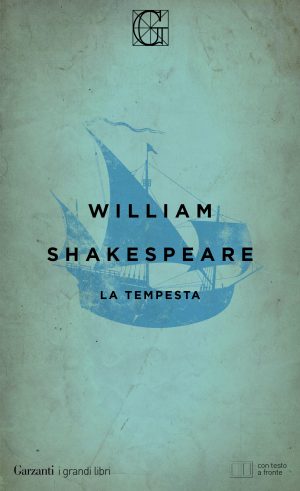«Congratulazioni» disse mia nonna al telefono con quella sua voce claudicante così piena d’entusiasmo. Io, che quella mattina già da più di un’ora vagavo per il parco, mi fermai in mezzo al vialetto. Sentii le labbra contorcersi in una smorfia che qualcuno avrebbe potuto definire un sorriso amaro.
Le parole mi uscirono lente, stanche, «Nonna, ancora non ho finito» e scuotendo la testa abbassai lo sguardo sulle mie scarpe. Era una bella giornata di giugno, di quelle che a forza ti penetrano nell’anima per instillarci un po’ di luce e calore, di quelle con gli uccelli che cinguettano e le voci dei bambini che giocano nei prati. Vidi una macchia di fango secco sulla punta delle scarpe e tentai di capire come me la fossi procurata, avendo camminato sempre e solo sulla strada asfaltata.
«Sei felice? E la cerimonia?»
Io chiusi gli occhi: «Sì, c’è la cerimonia, ma… i documenti. Prima devo consegnare alcuni documenti».
«Ah» fece lei, ma subito tornò alla carica: «Lunedì è la cerimonia, sì?»
Sospirai. «Sì» e dopo una piccola pausa aggiunsi «lunedì». Riaprii gli occhi. La macchia era ancora lì che mi aspettava e più la guardavo più mi sembrava che si allargasse sulla pelle nera degli stivaletti.
«Io ci vengo» disse lei, e potevo sentirla sorridere dall’altra parte del telefono.
«Sì» risposi io, «Sì». Risollevai gli occhi sui colori del mondo mordendomi il labbro inferiore.
Quando poi le sentii dire «Sono orgogliosa di te», quel mondo che avevo innanzi si sfocò all’improvviso e i colori si mescolarono come acquerelli dietro il velo umido che mi ricopriva le pupille. Mi passai la mano libera sugli occhi, uno ad uno, per liberarli di quel peso, poi sentii una brezza fresca soffiarmi sulle nocche bagnate.
Salutai la nonna e cercai una panchina dove sedermi. Tirai fuori dalla borsa a tracolla il manuale di rilievo architettonico e urbano e lo aprii a una pagina a caso. Dopodiché restai a lungo immobile e assorto guardando un punto indefinito davanti a me e quando rinvenni da quel torpore non potevo ricordare nemmeno se avessi pensato o sognato qualcosa.
«Dove sei stato tutta la mattina?» mi chiese mia madre quando tornai a casa per pranzo. Non c’era alcuna nota di rimprovero nella sua voce, soltanto un’onesta curiosità. Tutta impegnata a mescolare il ragù nel pentolone, concentrata sulla consistenza del sugo, non alzò lo sguardo su di me nemmeno per un istante.
«A studiare» risposi, e cercai un bicchiere pulito nella mensola. «Papà?»
«L’ho mandato a fare la spesa. Ma che c’è ancora, da studiare?» Si abbassò per annusare il vapore che saliva.
Io mi riempii il bicchiere e bevvi un lungo sorso d’acqua. Poi lo sciacquai e lo appoggiai sul lavandino a scolare. «Quando torna?» dissi, ma non ebbi risposta. Andai alla finestra e guardai fuori. Giù, in strada, c’era poco traffico. Approfittando della giornata di sole generoso molti avevano deciso di uscire a piedi o in bici. Vidi un gruppo di ragazzi fermarsi al bar sotto casa e, addossate le bici al muro del palazzo, sedersi ai tavoli all’aperto.
«Stamattina ha chiamato la zia» riprese mia madre. «Dice che vengono anche loro. Vengono in treno. Gli ho detto che è alle 11.00. È giusto, alle 11.00? Perché da lì ci vuole almeno un’ora per Milano. Gli ho detto di sbrigarsi, che passiamo noi a prenderli in stazione. O dici che c’è poco tempo? L’abito l’hai ritirato? Marco! Parlo con te!»
Io mi voltai verso di lei e incontrai i suoi occhi sottili che, finalmente soddisfatti del ragù, cercavano in me qualcos’altro da rimestare.
«Cosa?» domandai.
«C’è tempo? A che ora è la cerimonia?»
«Quale…? Alle 11.00, sì.»
Accigliata, mia madre riabbassò lo sguardo sul pentolone.
Mi avvicinai alla porta della cucina e mi fermai dandole le spalle. «A che ora torna papà?»
La sentii schioccare la lingua. «Mi sono pure dimenticata di dirgli di ritirare la corona d’alloro».
In camera mia tirai fuori lo zaino dall’armadio, pieno come l’avevo lasciato il giorno prima. Chiusi la porta a chiave e lo svuotai sul letto. Volevo ricontare tutto, controllare di non aver dimenticato nulla. Sette paia di mutande e altri sette di calzini. Li rimisi nello zaino appiattendoli sul fondo. Poi quattro magliette e due felpe. Non c’era più spazio per nient’altro. Andai allo scaffale con i libri e li rimirai uno a uno, anche se avevo già deciso che nella borsa a tracolla avrei infilato i racconti di Buzzati, quelli di Hemingway ed Erbe Selvatiche di Lu Xun. Presi tra le mani proprio quest’ultimo, ne accarezzai la copertina gialla, poi ne tirai fuori il biglietto del treno che avevo nascosto tra le pagine, comprato in contanti un mese prima. Lo osservai a lungo leggendo l’orario di partenza, la destinazione, persino i codici numerici e le norme sul retro e a un certo punto sentii dentro di me l’irrefrenabile impulso di scendere giù in strada e andare da quei ragazzi seduti al bar. Ci saremmo presentati, gli avrei offerto da bere, e dopo un drink o due, parlando dell’università, gli avrei raccontato tutta la verità, spiattellando i perché e i per come, i passi invisibili nella nebbia, la concatenazione di caos e di caso che mi aveva condotto impotente fin lì. E se poi fossero stati loro a offrire un altro drink a me, se poi ci fossimo messi a chiacchierare del più e del meno come se nulla di grave fosse mai accaduto, come se ci fossero ben altre cose a cui pensare, altri problemi nel mondo, altri eventi degni di maggiore interesse, ecco, allora sarei rimasto con loro. Avrei preso la mia bici, saremmo andati insieme al parco, lo stesso in cui mi ero nascosto per tante lunghe mattinate, e trattenendomi con loro fino al tardo pomeriggio avrei senz’altro lasciato che il treno partisse senza di me. Poi, una volta a casa, cenando con i miei avrei infine detto tutto anche a loro e un forte abbraccio e un pianto liberatorio avrebbero scacciato ogni dubbio, ogni cattivo pensiero, ogni maledetta bugia.
L’impulso si affievolì, poi svanì del tutto. Quei ragazzi non mi avrebbero offerto alcun drink. Si sarebbero scambiati uno sguardo incerto, avrebbero nascosto il sorriso imbarazzato dietro una bevanda, e io mi sarei ritirato in silenzio togliendoli dall’impaccio.
Sentii mia mamma parlare al telefono di là.
«Centodieci, sì! Con la lode. Non mi aspettavo altro da uno bravo come lui».
Chiusi gli occhi e feci un respiro profondo. Poi li riaprii, riposi il biglietto all’interno del libro e preparai anche la borsa. Indossai la giacca e guardai i miei occhi arrossati allo specchio. Non avrei aspettato un secondo di più, nemmeno che tornasse mio padre.